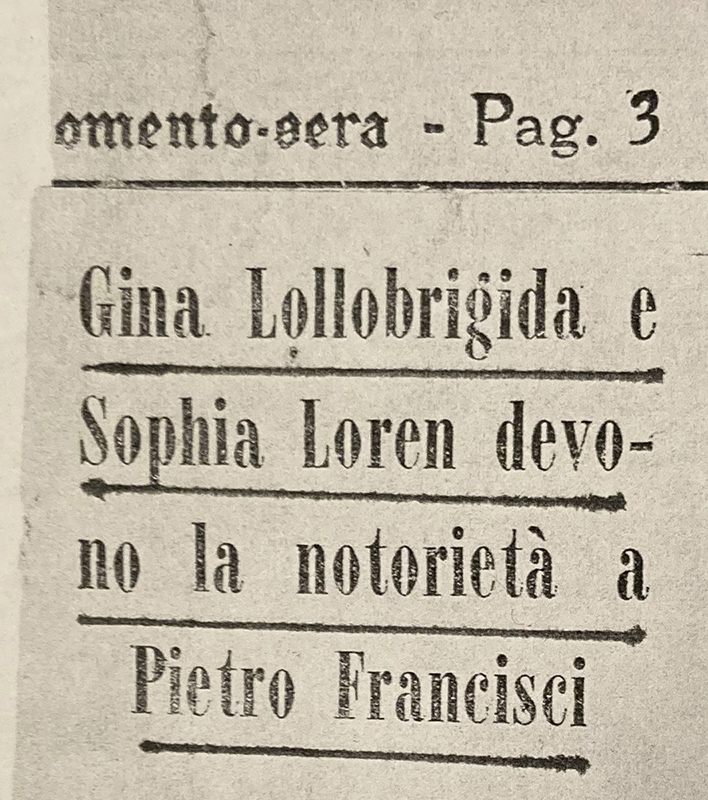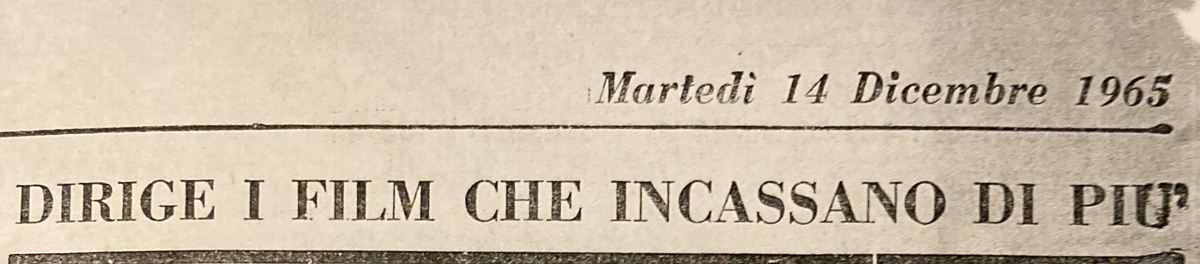Terza pagina Martedì 14.12.1965
di Maurizio Liverani
DIRIGE I FILM CHE INCASSANO DI PIÚ
GINA LOLLOBRIGIDA E SOPHIA LOREN DEVONO LA NOTORIETÀ A PIETRO FRANCISCI.
Troppo poco. Paragonare, dopo le sensazionali Fatiche di Ercole, Pietro Francisci a Cecile De Mille faceva ridere. Dopo Attila, in cui aveva lanciato Sofia Loren, lo battezzarono Cecile De Uno, dopo Orlando e i Paladini di Francia in cui aveva scoperto Rosanna Schiaffino lo chiamavano Cecile De Cento. Con Le Fatiche di Ercole si discusse a lungo nel mondo del cinema se bisognava chiamato Cecile De Centomille o Cecile De Un-Milion. C’è da dire che Francisci di bufale non ne ha fatte mai mentre il suo collega, buonanima, ne ha scritte alcune al suo passivo. Nel gergo dei romani l’attributo “bufala” viene dato a tutto ciò che cerca di ingannare in maniera grossolana l’altrui buona fede: tanto per fare un esempio una “bufala” era chiamata lo scorso anno la squadra di calcio della Roma perché partita con l’idea di vincere lo scudetto è stata sull’orlo del fallimento.
Francisci è una sorta di milite ignoto del nostro cinema. Come un atto turpe o una parola oscena gli venne addebitato il gran successo commerciale di suoi film secondo una consecutio logica che nel cervello dei suoi detrattori suona pressapoco così: “Se i suoi film incassano vuol dire che sono brutti”. Di dove sarà venuto tanto astio verso un fenomeno che in qualunque altro paese riempirebbe di orgoglio di soddisfazione e di fiducia? Registi oberati di “istanze” hanno sempre covato un malcelato fastidio verso questo distinto signore sul cui volto placido di romano, un po’ scocciato, un po’ melanconico, la furberia non si vede; ma ce n’è molta. Ebbe la furberia di stringere la vita e il busto di una attricetta in modo che il seno quasi si gonfiasse sulla scollatura e apparisse morbido e dolce. Fu così che “creò” Gina Lollobrigida in due filmati musicali, Stornellate romane e Na’ sera e’ Maggio. Il lungo allenamento alla bellezza femminile consentì a Francisci di afferrare al primo sguardo il grado di successo di Gina. Gina, da Francisci, andava cercando una iniziazione al cinema. Visto che tipo era egli la plasmò e da quel giorno il nome della Lollobrigida ci perseguita, sia detto senza la minima acredine e impazienza, monopolizzando tanto spesso le prime pagine dei settimanali.
Da autentico e grande luminare del sesso, Francisci ha sempre avuto per le belle donne una dissennata infatuazione, un totalitario entusiasmo, un fanatismo allergico ad ogni misura critica. In Antonio di Padova trovò il modo di mettere accanto alla figura mistica del santo, Aldo Fiorelli, una donna sino ad allora sconosciuta.
Trattandosi di Silvana Pampanini, Francisci propose un caso pieno di delicate incognite senza rinunciare agli scabrosi sottintesi. Le genuflessioni di Silvana si facevano nel film più pressanti e più inquiete e quella segreta punta di inconscia civetteria fu all’origine del suo successo. Perché, gira gira, i film di Francisci parlano sempre di donne, non con il gusto delle cose salaci e corrotte, bensì con autentico slancio. Egli è un meraviglioso cantastorie che canta di donne e dei loro amanti, di guerrieri e satanassi pieni di gagliardi appetiti e anche, perché no?, di desideri proibiti. Tutta la boria di Attila, che era Anthony Quinn, cadeva dinnanzi a Sofia Loren. Nel 55, anno in cui fu fatto il film, Sofia era un interrogativo. Nessuno riusciva a trovarle una collocazione sullo schermo. E’ troppo bella si diceva, è troppo alta accanto a lei gli uomini sembrano dei pigmei. Francisci rivelò all’attento Ponti quale effetto avrebbero fatto sullo schermo la bocca giovanile, le labbra schiuse in un subdolo sorriso, le sode carni e i seni pieni di Sofia accanto a quell’ iradiddio di Attila. Tutti gli eroi di Francisci hanno delle impellenze carnali. I suoi film sono una mescolanza di sacro e profano; l’angelo e il demonio vi coabitano.
Ma Francisci è anche uomo di cultura. Questi film che per materia, impianto, meccanismo, effetti vogliono essere manifestamente popolari, coincidono con un suo personale doppio gioco. “Nelle Fatiche di Ercole”, mi dice con l’aria di rimproverarmi una disattenzione, “Ho seguito la falsariga delle Argonautiche di Apollonio Rodio mentre per Ercole e la regina di Lidia mi sono ispirato a Edipo a Colono e I Sette a Tebe di Eschilo”. Il suo doppio gioco è appunto di sfruttare a fondo per il loggione le atouts, ma strizzando l’occhio ai borghesi istruiti. I suoi film pseudo storici o mitologici hanno salvato il cinema italiano nelle sue frequenti difficili congiunture. Ma non è solo per questo che lo chiamano “il medico”.
Una volta Roberto Rossellini gli chiese di cucirgli e dare un senso logico a un suo documentario sulla pesca del tonno. “Le immagini erano molto belle”, mi raccontò Francisci nella sua casa in viale delle Milizie a Roma, “ma sai come è fatto Roberto. Ogni tanto si entusiasma e fa cose formidabili, poi si stanca e lascia correre. Io ho preso il film, gli ho fatto qualche taglietto, gli ho dato un’aggiustatina. Insomma, ho fatto un bel lavoretto”. Tutti osannammo al “genio” di Roberto Rossellini.
Di registi testoni, mattacchioni o semplicemente sbadati Roma ne conta molti e c’è chi affida loro i propri soldi. I risultati sono “bufale”. Per farle poi diventare presentabili al pubblico si ricorre alle mignatte e ai senapismi del dottor Francisci. Prima di ogni consulto egli inforca gli occhiali, si piega sul moribondo, ausculta, fa la diagnosi, la prognosi e prescrive la cura. Francisci parla a voce bassa sottolineata da pochi gesti con una facilità che non degenera mai nella travolgente e sospetta oratoria di molti suoi colleghi registi. O meglio, non parla, conversa. Invano si cerca di ravvisare in lui quel titanismo dei registi ricchi che, come si sa, sono brutti animali insolenti e sfacciati che usano i loro soldi per impacchianire e rendere più vistosa la loro trivialità.
Francisci è conosciuto come “ il regista che ci ha li piroli”. I “piroli” sono i sostegni. In gergo romanesco uno che “ci ha li piroli” vuol dire che se ne intende. E questa definizione se la trascina dietro dal ’48 quando De Sica e Peppino Amato dopo aver visto in una città di provincia il suo Natale al campo 119 gli telegrafarono: “Bravo ci hai li pinoli”.
Un giorno armato del suo fiuto e della sua fede nel cinema spettacolare scopre in un giornale per ginnasti l’aitante, maiuscola figura di un insegnante di educazione fisica americano: si chiama Steve Reeves. Le ragazze spalancavano gli occhi alla vista di quel po’ po’ di fusto. All’arrivo di Reeves in Italia tutti i “fusti” indigeni tipo Maurizio Arena furono “ridimensionati”. Vedendolo i riferimenti erano facili sia alla storia sia alla mitologia. Steve era Ercole che nella culla aveva strangolato un serpente, era Giasone che combatteva per il vello d’oro; sarebbe potuto essere anche Cyrano anche d’Artagnan. Dopo le Fatiche di Francisci, quando si trattò di discutere i contratti questo poetico personaggio divenne il più prosaico dei ragionieri. “Oggi” mi dice Francisci con l’aria di un nonno che sorride alle prodezze di un suo nipote “possiede un patrimonio di un miliardo”.
In questi ultimi tempi, Francisci ha manifestato una tendenza a una posizione di distacco dal cinema. La molla che lo ha fatto scattare è stata l’idea di realizzare un film dall’Inferno di Dante. Si ferma all’Inferno perché a fare le scale forse gli viene l’affanno. Ma è ancora l’infatuazione per la bellezza che lo induce ad illustrare sullo schermo solo la prima parte della Divina Commedia nell’anno delle celebrazioni dantesche. Francisci si diverte a guardare con diletto i disegni di Dorè che sarà lo scenografo del suo film diviso in due puntate. Vediamo questo Inferno di Gustavo Dorè. Scorrendo le pagine, ci imbattiamo in una popolazione di Veneri tizianesche e giorgionesche più che botticelliane insieme con torme di Ercoli e Adoni. Mai un miserello, uno sciancato; e anche i vecchi, se pure rarissimi, michelangioleschi. E’ una prodigiosa carnalità sapientemente messa in valore. Urlano, piangono, si strappano i capelli, si dilaniano questi dannati ma con un esibizionismo anatomico che fa dimenticare tutti quei loro tormenti. Lo spettacolo cambia quando arriviamo al Purgatorio. La svogliatezza di Francisci di salire al Purgatorio corrisponde alla svogliatezza del disegnatore Dorè annoiato, anche lui, da quella pallida gente né troppo buona né troppo cattiva. In Paradiso, come Dorè, Francisci si troverebbe completamente disarmato perché qui i corpi non contano più; e dare un’idea plastica dei puri spiriti è impresa che scoraggiò qualcuno di ben più grande di lui: lo stesso Dante si giustifica, con un’ansia che commuove, della sua impossibilità di tradurre in parole l’ineffabile. A proposito, chi sarà Dante? “Sarà uno sconosciuto”, mi dice. Chi saranno Paolo e Francesca, belli per definizione? Chi Taide “sozza e scapigliata”? E chi Mirra? E Megera? Aletto e Tisifone con le ali di pipistrello? Chi Caronte e chi Plutone, maturi ma, secondo Dorè, gagliardissimi atleti? Bisogna attendere. Il film è solo in fase di preparazione. Della bellezza, specie della bellezza corporea, la gente ha una sete inestinguibile. E su questa persuasione Francisci imposta i suoi film che “fanno cassetta”.
Maurizio Liverani